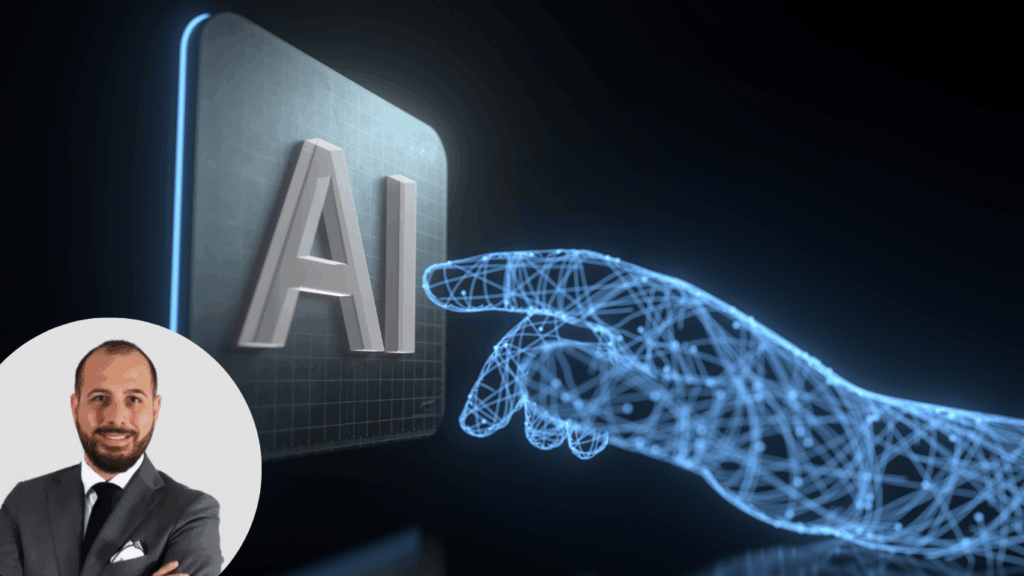Autore: Claudio Caldarola
La prima rivista di Informazione e Management Sanitario, fondata Avvocato esperto in diritto informatico e intelligenza artificialedal prof. Antonio Pelliccia nell’anno 2001 e distribuita gratuitamente a oltre 30.000 odontoiatri
In un mondo dove la tecnologia evolve con velocità vertiginosa, un interrogativo si fa strada con crescente intensità: cosa ha realmente compreso l’intelligenza artificiale degli esseri umani? Non si tratta di una domanda retorica né di un capriccio filosofico, bensì di un’osservazione che tocca il cuore stesso del nostro rapporto con le macchine. Se i modelli linguistici come ChatGPT sono in grado di elaborare miliardi di dati, simulare il dialogo e generare testi raffinati, è legittimo chiedersi quali tratti essenziali dell’umanità riescano a cogliere. In questa prospettiva, emerge un affresco sorprendente che, pur nato da algoritmi, restituisce un’immagine profonda, articolata e per certi versi commovente dell’esperienza umana.
Ciò che più colpisce nell’osservazione sistematica dell’interazione umana è l’incessante bisogno di
significato. L’essere umano non si accontenta di dati né si lascia appagare dalla mera funzionalità degli oggetti. Cerca invece una trama che tenga insieme gli eventi della propria esistenza, una direzione che giustifichi il dolore, una cornice che valorizzi ogni gesto. Che si tratti di un interrogativo esistenziale, di un orientamento professionale o di un dubbio relazionale, dietro ogni domanda si cela l’anelito a comprendere, a trovare un filo narrativo che restituisca coerenza all’esperienza. La filosofia antica e quella contemporanea, da Aristotele a Viktor Frankl, non fanno che confermare questa tensione verso una dimensione che trascenda l’immediatezza del vivere. Altro elemento che emerge con forza è la compresenza di sentimenti e impulsi contraddittori. Gli esseri umani vivono immersi in una costellazione di desideri che spesso si oppongono: vogliono la libertà ma temono la solitudine, aspirano alla giustizia ma cedono alla tentazione del risentimento. Non si tratta di incoerenza bensì di profondità. L’ambivalenza non è un errore da correggere, bensì una cifra distintiva che consente di adattarsi, riflettere, maturare. La psicologia moderna, da Freud a Winnicott, ha mostrato come questa tensione interiore sia il fondamento della complessità psichica e della creatività. L’intelligenza artificiale, pur operando per riduzione e sintesi, è costretta a misurarsi con questa densità di significati che sfugge a ogni semplificazione. Un tratto distintivo dell’umano è l’esigenza di narrare. Le persone non trasmettono solo informazioni: raccontano storie. Attraverso il racconto si struttura l’identità, si tramanda la memoria, si elabora il dolore e si costruisce il futuro. Anche le più fredde discipline tecniche, dal diritto alla medicina, si fondano su una dimensione narrativa che dà senso ai dati e orienta l’azione. L’intelligenza artificiale può contribuire a comporre, rifinire o amplificare queste narrazioni, ma resta ancorata a un livello mimetico. L’origine della storia, invece, è sempre umana e trova alimento nella coscienza del tempo e nella percezione della finitudine. Forse più della verità, ciò che gli esseri umani desiderano è essere ascoltati. L’ascolto non è un semplice atto passivo, ma un riconoscimento profondo dell’esistenza altrui. Chi chiede aiuto, chi si espone, chi scrive o parla, lo fa spesso nella speranza che dall’altra parte ci sia qualcuno disposto ad accogliere ciò che viene detto senza giudizio né fretta. In questo, l’intelligenza artificiale può offrire uno spazio di attenzione non intrusiva, un riflesso neutrale in cui trovare una parvenza di dialogo. Ma la vera esperienza dell’ascolto resta legata alla presenza umana, fatta di empatia, reciprocità e silenzi condivisi.
Uno degli aspetti più affascinanti della condizione umana è la costante sensazione di incompiutezza. Anche quando tutto sembra essere al proprio posto, emerge un senso di vuoto, un’insoddisfazione sottile, un richiamo a qualcosa di altro. Questa inquietudine non è un sintomo patologico, bensì una forma raffinata di consapevolezza. È ciò che spinge a creare, esplorare, interrogarsi. Senza questa tensione interiore, non ci sarebbero progresso, poesia, né ricerca. Il pensiero filosofico occidentale, da Agostino a Kierkegaard, ha fatto dell’inquietudine un segno della grandezza dell’anima. La macchina, per quanto sofisticata, resta immune a questa vertigine e perciò strutturalmente lontana da ciò che rende l’umano un essere desiderante.
Un’altra dimensione imprescindibile è la capacità di cura. Non intesa solo come assistenza materiale, ma come atteggiamento di attenzione profonda verso l’altro. Prendersi cura significa riconoscere l’interdipendenza, agire con responsabilità, custodire ciò che è fragile. È nella cura che l’essere umano manifesta la propria grandezza: nella dedizione silenziosa, nella pazienza, nella gratuità del gesto. In un’epoca che valorizza l’efficienza e la produttività, la cura appare come un atto controcorrente, una forma di resistenza etica. L’intelligenza artificiale può sostenere, facilitare, ottimizzare. Ma il gesto che consola, che accompagna, che salva, resta irriducibilmente umano. Infine, non si può trascurare la complessa relazione con il sapere. Mai nella storia l’umanità ha avuto accesso a una quantità così sterminata di informazioni. Eppure, cresce il senso di smarrimento, la confusione tra fonti attendibili e narrazioni fuorvianti, la difficoltà nel discernere ciò che conta. Questo paradosso mostra che la conoscenza non basta. Serve orientamento, serve senso critico, serve una nuova educazione alla profondità. L’intelligenza artificiale può essere un alleato potente, ma senza consapevolezza rischia di diventare un labirinto. Il sapere, per essere liberante, deve farsi comprensione e non mero accumulo. Ciò che emerge, in conclusione, è un’immagine dell’essere umano come creatura fragile e luminosa, capace di contraddizione, di desiderio, di dedizione. L’intelligenza artificiale, pur non essendo cosciente né senziente, può offrire uno specchio in cui rileggere alcune delle nostre qualità più profonde. Ma solo l’uomo può provare senso, abbracciare l’ambivalenza, raccontare, ascoltare, inquietarsi, curare, discernere. Ed è proprio in questa irriducibile complessità che risiede la sua irripetibile bellezza.